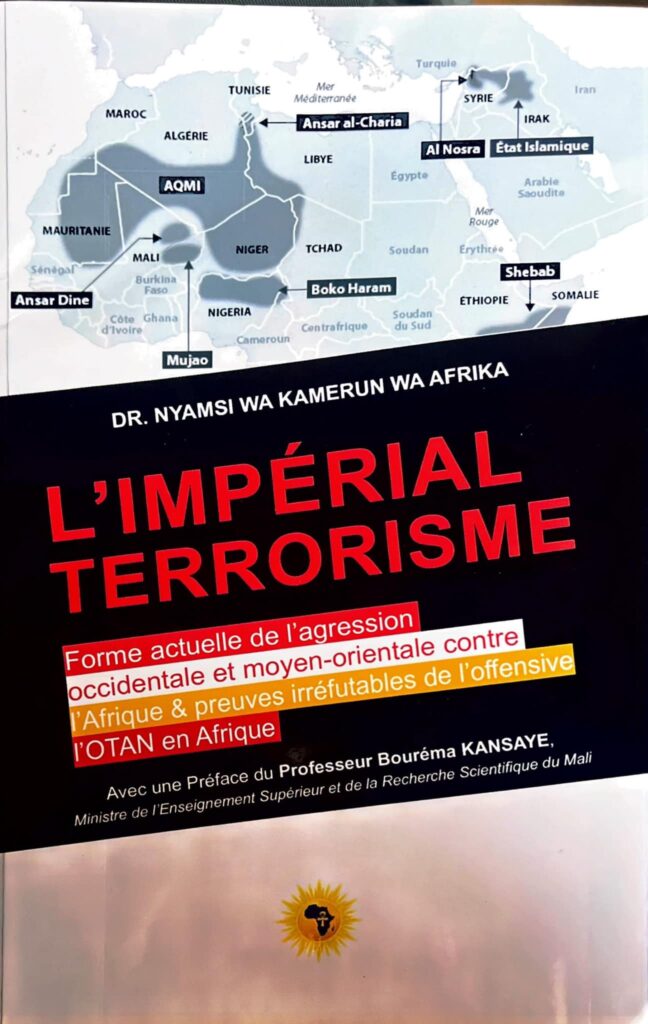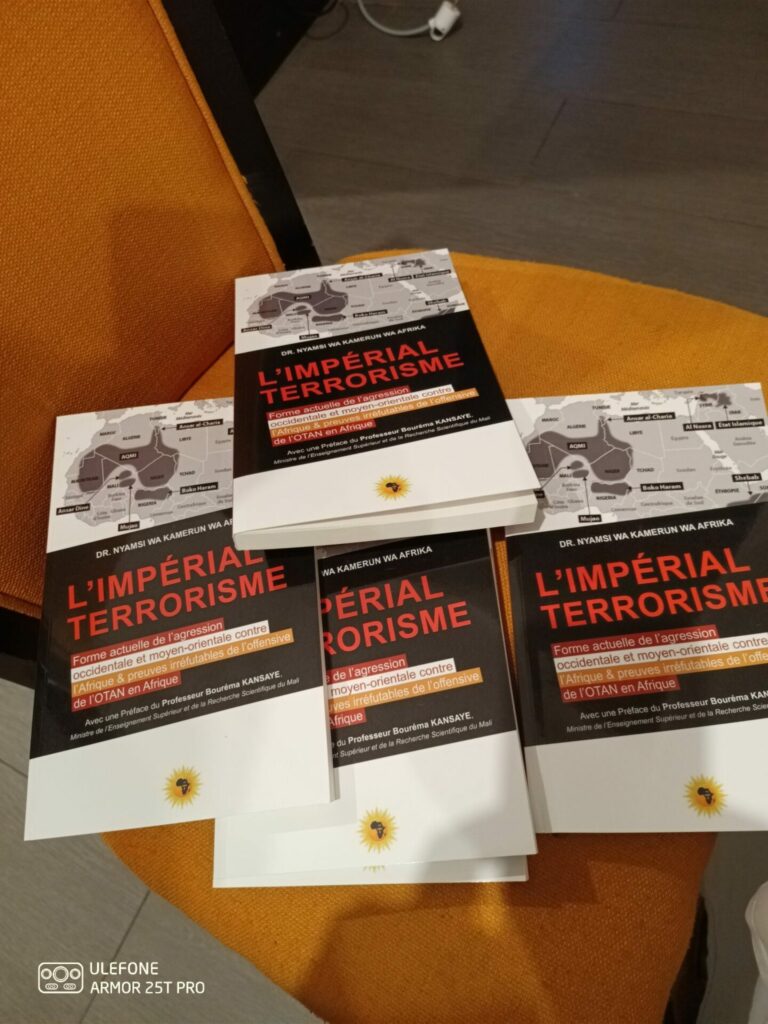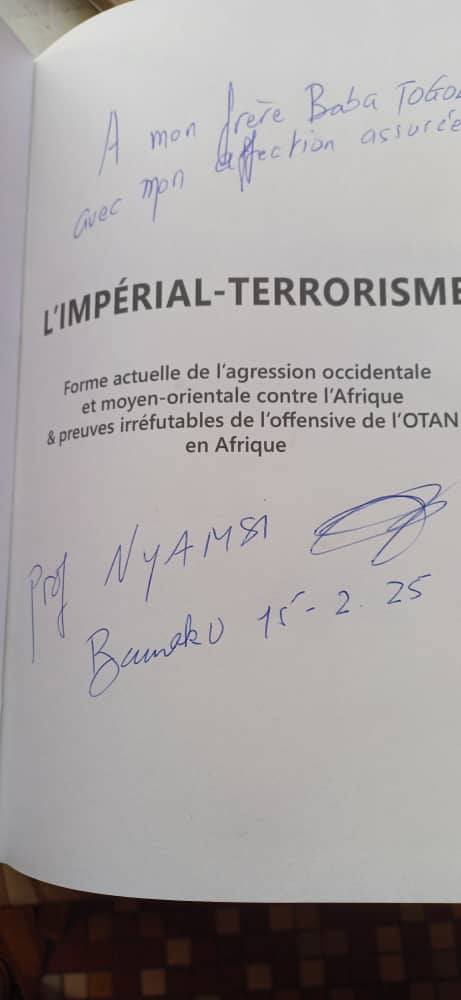Il procuratore capo della CPI Karim Khan ha richiesto a fine gennaio un mandato di arresto per i leader dei Talebani, accusati di aver commesso il crimine contro l’umanità di persecuzione di genere. Un atto importante per le donne perseguitate e per certi versi inedito ma che per essere efficace richiede che i Paesi occidentali e i firmatari dello Statuto di Roma rinnovino il sostegno alla Corte. Il commento del Coordinamento italiano a sostegno delle donne afghane.
Il 23 gennaio 2025 il procuratore capo della Corte penale internazionale (Cpi) Karim Khan ha lanciato un forte atto d’accusa nei confronti dei Talebani: ha richiesto l’arresto del leader supremo, Mullah Hibatullah Akhundzada, e per il suo giudice capo, Abdul Hakim Haqqani, perché ritenuti responsabili del crimine contro l’umanità di persecuzione di genere.
La documentata accusa sta in due lunghi e dettagliati documenti che danno il quadro dei crimini commessi dai Talebani in questi ultimi tre anni e mezzo e del ruolo diretto dei due accusati nell’architettare e sostenere la sistematica violazione dei diritti delle donne e delle persone Lgbtqi+, persecuzione commessa almeno dal 15 agosto 2021 e fino a oggi in tutto il territorio dell’Afghanistan.
È una decisione storica: per la prima volta una richiesta di indagine della CPI è incentrata sul crimine di persecuzione di genere come reato principale, e non solo per le azioni persecutorie contro le donne e le ragazze ma anche per quelle messe in atto nei confronti delle persone Lgbtqi+.
Un atto coraggioso, che supera i tentennamenti e le politiche contraddittorie dell’Onu e degli Stati cosiddetti democratici che rifiutano formalmente il riconoscimento del governo talebano ma intanto invitano i propri esponenti ai convegni internazionali e con loro fanno affari.
Finalmente qualcosa si muove anche a livello istituzionale in difesa delle donne afghane e del loro diritto all’esistenza. Qualcuno si è accorto della loro quotidiana insopportabile sofferenza e, andando oltre le astratte dichiarazioni in difesa dei diritti umani, si è esposto con un atto concreto.
Di fronte all’assoluta impermeabilità del governo talebano alle ingiunzioni delle istituzioni internazionali che richiedono il ritiro dei provvedimenti e il ripristino dei diritti delle donne, la risposta non può essere quella di cancellare il problema dalle agende politiche e recedere dalle pressioni per ingraziarsi i Talebani con concessioni commerciali e aiuti economici. E nemmeno quella di scommettere su una divisione del fronte talebano per poterne appoggiare gli esponenti più moderati, perché non ci sono Talebani cattivi e Talebani buoni: sono tutti comunque fondamentalisti.
La provata continuata oppressione delle donne in quanto genere e delle persone che non si conformano alla visione del mondo dei Talebani sarebbe stata meglio definita dal termine “apartheid di genere” (Adg), con il quale ormai da tutti viene nominata la persecuzione sistematica delle donne che avviene in Afghanistan, e in modo meno eclatante anche in altri Paesi. Ma la Cpi non poteva usare questo termine perché l’Adg non è un reato previsto dallo Statuto di Roma, che contempla l’apartheid basato sulla discriminazione etnica ma non sul genere.
Sebbene la CPI abbia cercato di aggiornare e integrare il reato di persecuzione di genere, l’Adg rimane una definizione più ampia e comprensiva di tutte le sfaccettature e gli aspetti politici che le differenze di genere comprendono. Perciò da varie parti si avanza la richiesta di rivedere lo Statuto di Roma integrandolo con il crimine specifico di Adg. Anche il Coordinamento italiano a sostegno delle donne afghane (Cisda) si unisce a questa richiesta nella sua “Campagna Stop fondamentalismi – Stop apartheid di genere” già avviata da novembre 2024.
Nel settembre dello scorso anno Canada, Germania, Australia e Paesi Bassi, seguiti successivamente da altre 20 nazioni, hanno annunciato la loro intenzione di deferire i Talebani presso il più alto tribunale delle Nazioni Unite, la Corte di Giustizia Internazionale, per le diffuse violazioni dei diritti umani contro le donne nel mancato rispetto della Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (Cedaw) di cui l’Afghanistan è firmatario. La procedura è in corso, vedremo nei prossimi mesi come andrà avanti.
Intanto, il 28 novembre scorso Cile, Costa Rica, Spagna, Francia, Lussemburgo e Messico hanno esortato il procuratore della CPI a indagare sulle violazioni sistematiche e continue dei diritti delle donne e delle ragazze da parte dei Talebani.
Accogliendo la loro richiesta, a fine gennaio, il procuratore, che aveva già annunciato la ripresa delle indagini sulla situazione in Afghanistan dopo un periodo di differimento, ha presentato le richieste di arresto per i due Talebani.
I giudici della CPI hanno tempo tre mesi per decidere se accogliere la richiesta. Se i mandati venissero emessi, i due uomini potrebbero essere arrestati in qualsiasi Paese membro della Corte, anche se, data la loro propensione a rimanere all’interno di Paesi amici, gli arresti e i processi sono in realtà una prospettiva lontana.
Potrebbe sembrare quindi un atto con scarse ricadute pratiche. Tuttavia, anche se questi mandati non dovessero portare all’arresto immediato e al perseguimento dei leader Talebani, avrebbero comunque l’effetto di danneggiare la loro posizione politica di fronte all’opinione pubblica mondiale. Rappresenterebbero un passo significativo nella lotta contro il riconoscimento internazionale del governo talebano, in un momento in cui molti Stati e l’Onu stesso si stanno adoperando per trovare giustificazioni umanitarie ed economiche che permettano di riconoscere al governo talebano il diritto a rientrare di fatto nella comunità internazionale nonostante la loro visione fondamentalista, condannata a parole da tutti gli Stati ma subita nei fatti in nome del pragmatismo.
La presa di posizione della CPI ci costringe a ricordare che è ancora viva la tragedia delle donne in Afghanistan, un Paese uscito dai radar mediatici sulla spinta di altre catastrofi più recenti e dalla consapevolezza che l’opinione pubblica spesso facilmente dimentica le tragedie appena escono dall’immediato presente. Ma soprattutto dovrebbe rendere evidente ai politici e alle istituzioni mondiali che impegnarsi con il governo dei Talebani, convocarli ai convegni internazionali, mediare con loro significa dare credibilità a un governo di criminali.
Per le donne vittime della persecuzione di genere la prospettiva aperta dalla CPI rappresenta una speranza di riconoscimento della gravità della loro sofferenza e del loro coraggio, ma se la giustizia vuole essere giusta non deve dimenticare le responsabilità dei Paesi occidentali. Nei vent’anni di guerra e occupazione le forze della coalizione, Stati Uniti in testa, si sono macchiate di numerosi atti di violenza e torture sulla popolazione civile.
Human rights watch (Hrw) e Amnesty international ricordano giustamente che tutte le vittime sono uguali e hanno uguale diritto al riconoscimento e al risarcimento, perciò la CPI non deve limitarsi a prendere in considerazione le vittime recenti del governo talebano ma deve invece riconsiderare le responsabilità di tutti gli attori in campo colpevoli di atti di barbarie, violenze, torture e ingiustizie che hanno provocato numerosissime vittime civili.
L’Afghanistan ha aderito nel 2003 al Trattato di Roma che ha istituito la CPI. Era il 2006 quando venne avviato un esame preliminare sui possibili crimini di guerra e contro l’umanità commessi in Afghanistan dalle varie parti, cioè l’esercito degli Stati Uniti e la Cia, le forze di sicurezza afghane e la rete dei Talebani e degli Haqqani. Ma fu solo nel 2017 che l’allora procuratore Fatou Bensouda chiese ai giudici della Camera preliminare di autorizzare l’indagine ufficiale.
Passarono anni di immobilismo in attesa che si decidesse quale ambito di inchiesta fosse consentito effettuare. E quando nel 2023 è stato concesso di includere nelle indagini anche i recenti “nuovi attori” oltre ai responsabili dei venti anni precedenti, Khan ha deciso di concentrare le sue inchieste sui Talebani e sull’Iskp, escludendo di fatto la Cia, l’esercito statunitense e le forze della Repubblica afghana dalla sua competenza, considerando troppo oneroso condurre ricerche su casi di così ampia portata.
Una decisione forse realistica ma che ha creato una “gerarchia nelle vittime” determinata dall’identità del presunto autore, invece che dalla portata e gravità dei crimini. “Un insulto a migliaia di vittime di crimini commessi dalle forze governative afghane e dalle forze statunitensi e della Nato”, come l’ha giustamente definita un’attivista afghana.
La CPI sta affrontando in questi giorni una pressione significativa a livello internazionale, che potrebbe avere conseguenze sulle sue indagini e sulla sua stessa esistenza. Gli Stati parte dello Statuto di Roma che governa la Corte, tra cui l’Italia, dovrebbero confermare l’importanza di questa istituzione e supportare concretamente l’esercizio del suo mandato indipendente, garantendole con il sostegno e l’assistenza pratica la possibilità di espandere le sue indagini in Afghanistan.
Beatrice Biliato fa parte del Coordinamento italiano a sostegno delle donne afghane (Cisda)
altreconomia